Farsi ispirare dal naufragio - da "Botanica della Meraviglia"
Un estratto dal nostro "Botanica della meraviglia. Coltivare lo stupore alla fine del mondo" (Harper Collins), in uscita domani, 14 ottobre.
Leggenda vuole che la notte del 14 aprile 1912 otto musicisti abbiano fatto qualcosa di apparentemente assurdo: mentre la nave su cui si trovavano affondava nelle acque gelide dell’oceano Atlantico, anziché cercare di salvarsi, continuarono imperterriti a suonare.
Sarebbe ingeneroso definire quello dell’orchestra del Titanic un puro gesto teatrale, una trovata per mettersi in mostra, una scelta mossa dalla vanità: la notizia in quel momento, del resto, era che la nave più grande del mondo stesse colando a picco durante il suo primo viaggio. Nessuno era interessato a quel gruppo di suonatori che nel frattempo, invece di scappare, aveva deciso di suonare il proprio ultimo concerto. Eppure, quella scelta è stata commentata, giudicata, disprezzata o elogiata per più di un secolo, perché mette di fronte a una domanda scomoda: cosa ha senso fare quando il mondo intorno a noi sta crollando?
Nel film Titanic di James Cameron, in cui i personaggi interpretati da Kate Winslet e Leonardo DiCaprio vivono un amore che durerà pochi giorni e finirà in tragedia, la scena avviene così: i musicisti all’inizio provano a scappare insieme agli altri portandosi dietro gli strumenti, finché uno di loro non si ferma e decide di suonare il violino. È allora che il resto del gruppo si volta, si avvicina e inizia a fare lo stesso, mentre la situazione intorno diventa sempre più critica. La scena si conclude nel momento in cui il violinista e guida dell’orchestra, Wallace Henry Hartley, pronuncia la celebre frase: «Signori, è stato un onore suonare con voi stasera».
Hartley verrà ritrovato con il suo strumento ancora legato al corpo: un violino che, recuperato e autenticato nel 2013, sarà venduto all’asta per oltre 1,7 milioni di dollari (tutto molto, molto statunitense). Una reliquia che testimonia un fatto storico preciso: quegli otto uomini scelsero consapevolmente di non salire sulle scialuppe di salvataggio e di continuare a suonare. Lo fecero prima nel salone principale e poi sul ponte della nave, mentre il panico montava e la fine si faceva inevitabile.
Non sappiamo con certezza quale fu l’ultimo brano eseguito, ma secondo alcuni sopravvissuti si trattava di Nearer, My God, to Thee, ossia “Più vicino, mio Dio, a Te”. È un inno che racconta di come, anche nel buio più totale, anche quando il sole è tramontato e non hai altro che una pietra come cuscino, puoi trasformare la tua sofferenza in qualcosa di utile.
Though like the wanderer, the sun gone down, / darkness be over me, my rest a stone; / yet in my dreams I’d be / nearer, my God, to Thee.
Benché come il viandante, tramontato il sole, / le tenebre mi avvolgano, il mio riposo una pietra; / pure nei miei sogni io sarò / più vicino, mio Dio, a Te.
In effetti, l’orchestra stava vivendo esattamente la situazione descritta dal brano: le luci della nave si stavano spegnendo, l’acqua saliva e il terrore cresceva inesorabile. Eppure, tutti loro avevano scelto di prendere in mano quel momento di puro orrore e dargli una forma e una dignità attraverso la musica. Non sopravvisse nessun membro del gruppo, e il brano fu poi suonato al funerale di Hartley.
Quale fu la ragione di quella scelta? Forse i musicisti volevano lasciare spazio sulle scialuppe, anziché cercare di salvarsi la vita, come fecero tanti altri uomini in quelle ore? Forse intendevano calmare i passeggeri, come sostenne qualcuno? Forse entrarono in un delirio poetico, oppure non si resero conto di quanto fosse grave la situazione? È possibile – o meglio, ci piace pensare – che, in un momento così concitato, si siano domandati quale fosse il proprio posto, a quale vocazione dovessero rispondere. Ed è possibile – anche qui, ci piace pensare – che la risposta sia stata una forma straordinaria di assurda e splendida coerenza, di insubordinazione al caos.
Ma cosa succede quando proviamo a portare questa storia nella nostra vita quotidiana, non per farne un esempio eroico o utopistico da guardare da lontano, ma per osservare in che punto ci troviamo oggi? Perché la sensazione di essere su una nave che affonda sembra una costante del nostro tempo: scenari sempre più apocalittici ci impediscono di vivere serenamente il presente e di immaginare il futuro sia in una dimensione personale sia a livello collettivo. La crisi climatica che avanza con dati sempre più allarmanti, le democrazie che si sgretolano, le guerre sulla pelle dei civili, il collasso economico e sociale, le disuguaglianze crescenti. L’intelligenza artificiale che sta trasformando tutto, mentre scriviamo ancora a mano le liste della spesa. È come se vivessimo in un eterno momento di transizione, in cui il vecchio mondo non ha ancora finito di morire e quello nuovo non ha ancora iniziato a nascere. Ma non nasce mai.
Suonare mentre tutto affonda
Se è vero che ci troviamo tutti nella stessa tempesta, le possibilità di salvezza non sono equamente distribuite: come sul Titanic, c’è uno scarto enorme tra la prima e la terza classe. È già così quando tutto sembra andare bene, ma quando la situazione è critica le distanze diventano incolmabili, i posti sulle scialuppe sono pochi e bisogna scegliere chi salirà e chi no. Come quei musicisti, ci chiediamo che senso abbia continuare a suonare. A che scopo dedicarsi alla cultura, all’arte, alla conoscenza, persino all’uncinetto, mentre tutto intorno sembra sul punto di crollare, di disfarsi? Perché studiare, se è diventato così immediato ricevere risposte da strumenti “esterni”? Ha senso avere figli, se il futuro è tanto incerto e fosco? E perché continuare a lavorare?
In questo spazio sospeso, ognuno di noi si trova a dover scegliere, ogni giorno, cosa vale la pena continuare a fare. E qui emerge qualcosa di più complesso del semplice dilemma individuale: queste scelte non avvengono nel vuoto, ma dentro relazioni, comunità, sistemi che ci precedono e ci attraversano. Come quei musicisti che decisero insieme – non ciascuno per conto proprio, bensì come gruppo – di continuare a suonare, i nostri non sono solo dilemmi personali. Sono le crepe attraverso cui si può intravedere qualcosa di più profondo: il modo in cui (non) stiamo imparando a stare insieme in questo tempo di transizione. Come società, come specie, come abitanti di uno stesso pianeta che non sappiamo più abitare.
Perché, mentre ognuno di noi si interroga privatamente sul senso di quello che fa, contemporaneamente si sta giocando una partita collettiva di cui spesso non ci accorgiamo. Moltissime persone stanno vivendo un totale disorientamento, uno stato di stanchezza cronica e mancanza di entusiasmo, una condizione di affanno che non lascia mai la presa e che troppo spesso viene raccontata come una condizione individuale, e che dunque va risolta a livello personale. Al contempo, ci troviamo ad affrontare una domanda simile ma più complessa: come si fa a suonare insieme quando non condividiamo più né la musica né l’idea di cosa significhi “insieme”? Come si costruiscono forme di resistenza culturale in un’epoca che sembra aver frantumato ogni possibilità di cultura comune?
Sono le domande che emergono quando usciamo dalle nostre stanze private dell’ansia e proviamo a guardare il panorama più ampio. Quando ci accorgiamo che mentre ci interroghiamo sul senso del nostro pianoforte, qualcun altro (molto ben organizzato) sta smantellando sistematicamente l’idea stessa che il pianoforte possa avere un senso.
Una stanchezza senza nome
Mettiamo le carte in tavola: è abbastanza assurdo continuare a studiare mentre il mondo crolla. È anche assurdo scriverci un libro. Non solo assurdo: osceno. L’atto stesso di studiare e scrivere richiede una forma particolare di fiducia nel futuro. Non la sopracitata speranza ingenua che “andrà tutto bene”, ma la convinzione profonda che il sapere possa attraversare il tempo, che valga la pena costruire competenze complesse e che il significato possa in qualche strano modo sopravvivere al caos, e persino fiorirvi dentro. Eppure, cosa succede quando questa fiducia viene meno? Quando diventa sempre più chiaro che non solo non andrà tutto bene, ma che probabilmente andrà tutto ben peggio di quanto riusciamo, vogliamo e possiamo immaginare?
C’è una forma evidente di follia nel continuare a studiare in queste condizioni. Come quei monaci irlandesi che, nel pieno del collasso dell’Impero romano, copiavano meticolosamente manoscritti mentre i barbari bruciavano ogni cosa tutt’intorno. O come quegli scienziati che continuano a studiare specie in via d’estinzione, documentando accuratamente la fine di qualcosa che non tornerà più. O come chi studia letteratura antica oggi, che non solo deve fare i conti con la precarietà economica, la mancanza di tempo, l’ansia per il futuro, ma deve anche confrontarsi con una domanda più radicale: che senso ha preservare questa conoscenza morente in un mondo che sta andando a fuoco? Non sarebbe più onesto – e più urgente, più necessario, più utile – dedicare tutte le energie a cercare di spegnere l’incendio?
La risposta facile c’è, e sarebbe dire che la cultura serve proprio per affrontare meglio la crisi. Che la cultura è un grandioso estintore che nei millenni abbiamo usato per spegnere i molti incendi causati dalla stupidità umana. Sarebbe una bella risposta, però parziale. Il fatto è che buona parte di quello che studiamo non serve a niente; non nel senso immediato del termine, quantomeno. Non ci aiuterà a ridurre direttamente le emissioni di CO₂, a gestire i flussi migratori o a risolvere le disuguaglianze sociali o a ridistribuire la ricchezza, in un mondo in cui il patrimonio dei dieci uomini più facoltosi al mondo è cresciuto, in media, di quasi cento milioni di dollari al giorno, mentre poco più di 3,5 miliardi di persone vivono sotto la soglia di povertà (fonte: dati Oxfam, 2025). E allora?
Allora forse il punto è proprio questo: continuiamo a studiare proprio perché è inutile. Proprio perché è assurdo. Proprio perché non ha senso. In un mondo ossessionato dall’utilità, dalla produttività, dall’ottimizzare ogni istante, dal capitalizzare su ogni dettaglio, è sovversivo dedicare (e buttare) tempo ed energie su qualcosa che non serve a niente. È un atto di resistenza silenziosa al trito imperativo dell’efficienza. Come recita una scritta su un muro di Bologna: “In una società che obbliga all’eccellenza, fare schifo è un gesto rivoluzionario”. Non è romanticismo. È un modo di abitare lucidamente l’assurdo. Studiare al tempo della fine del mondo – letterale o metaforico, poco importa – significa accettare questo paradosso: sapere che probabilmente è tutto inutile, e farlo lo stesso. Non per eroismo o per resistenza, ma perché in questo continuare si nasconde una forma di libertà che il collasso non potrà mai toccare.
Questo è un estratto dal primo capitolo del nostro Botanica della meraviglia. Coltivare lo stupore alla fine del mondo (Harper Collins), da domani in libreria.
Si trova anche su Tlon.it Librerie indipendenti IBS Mondadori Store LaFeltrinelli Amazon



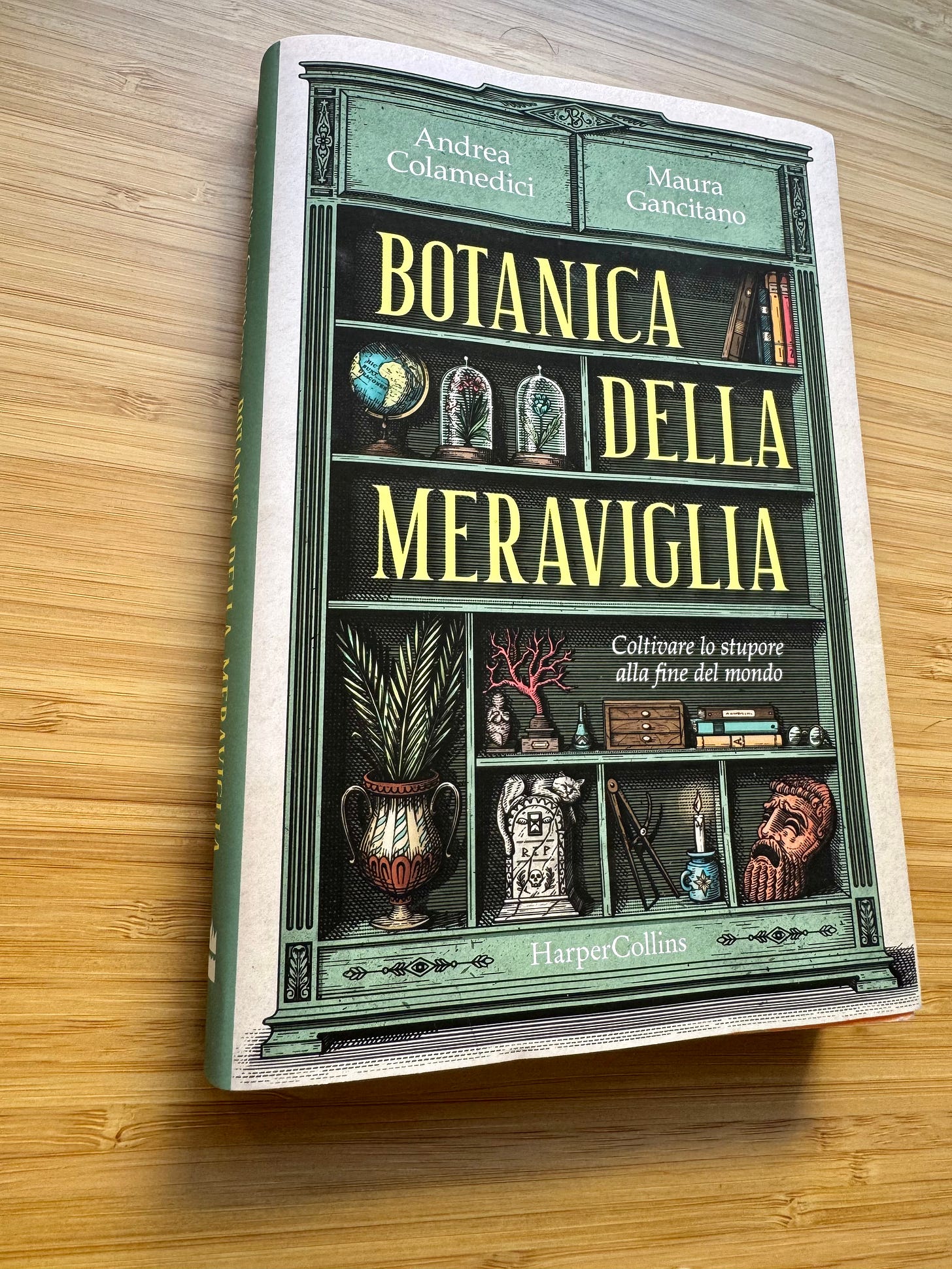




A leggere questo articolo la prima cosa che ho pensato e’ stata “Meno male che esiste Tlon”. Con il vostro sguardo “ricentratore” sulle questioni importanti e le vostre analisi su questo mondo assurdo che abitiamo (assurdo in senso negativo ahimè..). Grazie di cuore.
E giustamente si parla di dedicare tempo e energie alla cultura, che appunto non serve a niente. Pensa, invece, quando tempo e energie si dedicano alle cose utili, scrivere mail, rispondere al telefono, appuntamenti, le banali attività quotidiane, come se nulla fosse, pensando che la nave non affonderà mai, senza sapere se è solo irriducibile ottimismo - più o meno consapevole - o catalessia, ipnosi, trance ... Però, mi viene male leggere che la cultura (e gli esempi di studio citati sopra) non servano a niente. Anche se fosse vero, vorrei che lo fosse solo nel contesto dell'articolo. Come paradosso.